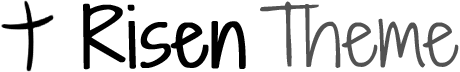La profezia vive. Anche dopo la morte del profeta. Nonostante l’apparente supremazia dell’organiz-zazione del potere clericale, «struttura di peccato» che genera connivenze corruttive, la spada affilata a doppio taglio dei profeti, anche se morti, si affonda nella carne viva della coscienza. Anche se morti? Forse sarebbe meglio dire «specialmente se» morti, perché la Parola di Dio, che il profeta custodisce senza tornaconto per sé, è inarrestabile. Può essere ritardata o imbrigliata, ma mai tacitata, perché «le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma di dio!» (Ct 8,6). La profezia scritta che scende sempre dal monte Sìnai e dal monte Gòlgota, è il nuovo nome dell’Amore perché si compie in una relazione feconda, generativa.
Con il suo grido pacato e forte, il profeta scardina l’ovvietà banale della religione, costringendoci a tornare «al principio» di noi stessi, alle profondità del «Dio nascosto», così diverso dal «dio noto» cui siamo abituati, dimenticandone il volto, fino a farne un idolo a nostra immagine. Siamo sicuri che il «dio nostro», il «dio cattolico» che ci accaniamo a sventolare come trofeo o arma contundente contro «gli altri», sia il «Padre del Signore nostro Gesù Cristo» (Rm 15,6)? Dubitare possiamo, interrogarci dobbiamo…